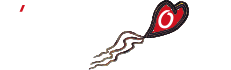Intervista al fondatore
1) Come è nata l’idea dell’Associazione?
L’Associazione affonda le sue radici storiche e di idealità nell’esperienza di impegno sociale a favore degli “ultimi”, mio personale di allora sacerdote e della Comunità Cristiana di Base di Formia che animavo negli anni ’70.
In seguito, agli inizi degli anni ’80, l’esperienza, sempre attraverso l’impegno personale, ma da allora come psicologo, in collaborazione con un gruppo spontaneo di studenti in psicologia, altri psicologi e familiari di persone con disagio psico-fisico ed in difficoltà, si è andato caratterizzando come esperienza rivolta al mondo sofferto del disagio psico-fisico.
In quegli anni il programma è stato articolato in una serie di incontri pomeridiani con momenti di animazione, di gioco, di socializzazione.
2) Quando si è concretizzata la costituzione dell’Associazione?
Il lungo cammino, fatto sì di difficoltà, ma anche di soddisfazioni, percorso dal gruppo di cui dicevo pocanzi, ha dato vita ad un’esperienza, all’inizio spontanea, poi costituitasi nel 1993 in Associazione di Volontariato, per gestire una “Casa Famiglia” ed un “Centro Diurno” per persone con problemi psico-fisici: un’esperienza che si fonda su un semplice, sincero, ma spesso poco compreso, “rapporto umano”.
Difatti, agli inizi del 1993, ispirandoci ai principi della Legge Quadro Nazionale sul Volontariato n. 266/1991 abbiamo costituito l’”Associazione di Volontariato L’Aquilone”; l’Associazione, avendone i requisiti, nel 1995 è stata iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, Sezione Servizi Sociali della Regione Lazio.
3) Cosa ti ha spinto a creare questo spazio per i disabili?
Guardando indietro mi sono chiesto cosa avesse spinto me e gli operatori dell’ “Aquilone” a “creare” uno spazio di incontro con persone che nel gergo abituale erano considerate “emarginate”, “escluse”, “alienate”, “diverse”.
La risposta l’abbiamo trovata nell’esigenza, nata nel profondo dell’animo di ciascuno di noi, di creare con le persone in difficoltà, escluse dal tessuto vivo della nostra società, uno spazio di vita in cui venisse rispettata la loro dignità di esseri umani; uno spazio in cui potessero giungere a comprendere che anche loro hanno il sacrosanto diritto di esprimere pienamente la loro esistenza; uno spazio in cui potessero avere la libertà di comunicare ciò che sentono dentro, nel loro animo, senza sentirsi addosso il “marchio” del “giudizio” o, ancora peggio, del “pregiudizio”.
4) Quali erano gli intenti che hanno guidato il vostro impegno?
Gli intenti iniziali erano proprio questi: creare uno spazio di vita comunitaria in cui ogni persona potesse essere artefice della propria vita e potesse giungere, lontano dagli opprimenti e difficili ambienti familiari e sociali, ad un completo riconoscimento della propria soggettività, cercando, in seguito, di riportare questo modello di vita e le nuove acquisizioni anche all’esterno, nelle proprie famiglie e nella società.
Nei nostri intenti infatti non c’è stata mai, e non ci sarà mai, l’idea di costruire la cosiddetta ”isola felice”, ben consapevoli del rischio reale che tale isola possa trasformarsi in un “ghetto”, in uno spazio isolato dal contesto città, in uno spazio ai margini del tessuto sociale, in ultima analisi con una esclusione di fatto dal vivere quotidiano della città.
5) Quali sono state le difficoltà che avete incontrato?
Inizialmente, a parte le difficoltà di ordine logistico (trovare la casa è stato un vero dramma), tutto sembrava bello: il dedicarsi appieno ai primi ragazzi venuti al Centro dava ad ognuno di noi operatori una carica ed una vitalità che ci ha spinto a superare le prime difficoltà legate al cosa fare, come organizzare le giornate, come comunicare con loro.
6) Raccontaci dei primi tempi del vostro impegno.
In principio i ragazzi erano solo due, avevano problemi di carattere diverso, dinanzi ai quali ci ponevamo essenzialmente con il nostro bagaglio umano ed affettivo e con loro comunicavamo, crescendo insieme, vivendo insieme una vita in cui l’unica preoccupazione era che quei due ragazzi potessero sentire (così come lo sentivamo noi), più di ogni altra cosa, di avere vicino degli amici, delle amiche che erano in grado di condividere, accettandoli, i problemi che giorno dopo giorno ci trovavamo ad affrontare.
Devo dire che non è stato facile: c’era Pietro*, un ragazzo che portava dentro di sé tanta di quella sofferenza e tanta di quella amarezza che aveva deciso di chiudersi in un mondo tutto suo in cui accentrava la sua esistenza e non gli consentiva di vivere una vita di relazione serena.
Un momento importante per Pietro era quando tutti insieme ci mettevamo lì con lui a ballare e cantare le sue canzoni preferite, soddisfacendo quei suoi desideri che per noi rappresentavano il nostro modo di comunicargli quanto gli fossimo vicini.
C’era Carmela* una ragazza molto giovane, con disturbi di carattere intellettivo, che fino ad allora non aveva avuto contatti con altre persone se non con i suoi familiari più stretti. Noi diventammo per lei dei referenti importanti in quanto con noi cominciava a vivere una vita più ricca, aveva persone intorno che la stimolavano a parlare, ad esprimersi, che provavano piacere nel conoscerla e nel volerle bene, così, in modo sincero e senza nessuna remora.
Si trattava, quindi, proprio di una piccola famiglia in cui ciascuno contribuiva alla crescita dell’altro.
Ma la famiglia cominciava a diventare più grande e le persone nuove che venivano cominciavano a metterci di fronte a nuovi problemi di organizzazione, di gestione e di vita.
Non bastava più lo stare insieme e lo svolgere attività ludiche e psico-pedagogiche; i ragazzi avevano bisogno, e di questo ci andavamo sempre più rendendo conto, di spazi attivi in cui ognuno potesse esprimere, anche materialmente con il proprio lavoro (oltre la gestione della casa), ciò che era in grado di fare, rinforzando, giorno dopo giorno, anche la propria dignità di soggetto attivo in grado di produrre lavoro.
Allora abbiamo sentito l’esigenza di offrire ai ragazzi la possibilità di cominciare a svolgere delle attività come la pittura su stoffa e sul vetro, il cucito, una piccola falegnameria, ecc.
Inizialmente queste attività erano state concepite come veicoli, come mezzi: non era tanto importante il prodotto finito, ma l’attività intesa come mezzo per trasmettere e per ricevere accettazione (va bene qualunque cosa tu faccia) e considerazione positiva (tu hai delle potenzialità tue che vanno rispettate).
Fu questo un momento importante di crescita perché ognuno riconosceva in quel lavoro una parte di se stesso.
Le potenzialità di ognuno crescevano e si rafforzavano perché c’era la volontà di accrescerle, e perché, attraverso la fiducia e la stima reciproche, che erano alla base del vivere quotidiano, ogni persona era in grado anche di riportare questi vissuti e questo ottimismo soprattutto all’esterno.
7) Quindi dopo le prime difficoltà tutto si è appianato?
No, non è stato tutto così semplice: con l’arrivo di altri ragazzi cominciavano a crearsi anche i primi conflitti interni, le prime gelosie, i primi innamoramenti, per cui ci siamo trovati, man mano che andavamo avanti, dinanzi a nuovi vissuti che i ragazzi sperimentavano, ma che nel contatto quotidiano si riuscivano ad affrontare, perché queste nuove problematiche relazionali non solo venivano esperite, ma finalmente avevano la possibilità di venire comunicate e gestite con una nuova consapevolezza.
Vivere insieme significa anche tutto questo, significa cominciare a provare nuove e profonde emozioni da cui però non ci si deve lasciare sopraffare, ma che si possono imparare a gestire.
L’esperienza è andata progressivamente evolvendo, il piccolo nucleo familiare cominciava ad estendersi, ogni volta si richiedeva un nuovo assetto, perché ogni nuovo ragazzo portava esigenze e problemi diversi che ponevano noi operatori dinanzi a nuovi interrogativi e a nuovi impegni.
A volte qualcuno di noi si è rimproverato e ci si rimprovera tuttora, pensando che il proprio atteggiamento rischia di essere più di protezione che di spinta, più di difesa che di stimolo verso l’autonomia.
Ma ci rendiamo conto che inizialmente ogni ragazzo che viene all’ “Aquilone” ha bisogno di comprensione empatica, non difensiva ma sincera, ha bisogno di solidarietà, ha bisogno essenzialmente di affetto, di quell’affetto che molte volte da solo è in grado di generare una persona nuova, una persona aperta e non spaventata, una persona che non ha bisogno di “nascondersi” dietro una patologia che la “castiga” per anni o per sempre dietro una maschera fragile che può, da un momento all’altro, stigmatizzarsi come una realtà grazie al contributo negativo di tanti rifiuti, di tante contraddizioni, di tante storture, e di tanti giudizi che finiscono per diventare un’autodeterminazione del disturbo psichico.
8) Sono pertanto i rifiuti, le contraddizioni e i giudizi che rafforzano il disturbo psichico?
Questi ragazzi hanno imparato nella loro sofferenza che sono diversi, che ad esempio i ruoli attivi, lavorativi e creativi non competono loro, che nessuno si interessa a ciò che dicono se non per fare una diagnosi e, quindi difficilmente riescono ad avere un autentico “vissuto personale” positivo di se stessi.
Anche nelle relazioni familiari di solito ci sono delle tappe che caratterizzano l’esperienza complessa e sofferta di coloro che hanno una relazione di parentela con il cosiddetto “diverso” e che ne rafforzano purtroppo il giudizio negativo e la visone negativa della loro realtà.
In genere da una prima fase di disorientamento, si passa ad una fase di scoraggiamento, poi ad un’accettazione purtroppo solo apparente, e solo in rarissimi casi si riesce a raggiungere un’accettazione autentica.
Proviamo a pensare alle possibili reazioni dei familiari: ai sensi di colpa legati a possibili tare ereditarie, all’alternarsi di speranze e di scoraggiamento, ai non poco problemi quotidiani connessi con la presenza di una persona “anomala” in famiglia, all’ansia per il futuro quando loro non ci saranno più: quanta è drammatica la solitudine dei familiari.
9) Ma i familiari sono ancora realmente soli?
Sulla drammatica solitudine dei familiari si innesta il lavoro prezioso degli operatori dell’”Aquilone”: prima di tutto si cerca di scardinare un ruolo, un’etichetta, quello di “malato mentale”, attraverso il quale queste persone da un lato danno un senso alla propria sofferenza personale e dall’altro trovano una loro collocazione rispetto agli altri e al di fuori della famiglia.
E’ dunque nelle relazioni interpersonali e nel favorire il protagonismo delle famiglie che va individuata la chiave di lettura dell’esperienza della Comunità l’”Aquilone”.
Non è possibile descrivere con le parole queste relazioni e il protagonismo delle famiglie, sarebbe troppo riduttivo; ricordo solo che a fondamento del nostro impegno di servizio e di condivisione ci sono sentimenti di empatia e di accettazione tali da consentire ai ragazzi una ridefinizione del Sé e della propria identità personale e sociale.
10) Ci puoi fare qualche esempio?
Penso ai primi tempi di Francesco*.
Il suo corpo era molto rigido, il viso senza espressione, poco coinvolto in qualsiasi attività che gli veniva proposto, seduto sempre su una poltrona che rappresentava per lui forse il luogo protettivo dove potersi rifugiare.
Oggi il suo modo di relazionarsi con se stesso e con gli altri è molto cambiato.
Coinvolto in attività spesso partecipa attivamente, ha stabilito rapporti di amicizia con quasi tutti i membri del Centro e, cosa più importante, ha cominciato a parlare di sé, delle sue difficoltà e del suo desiderio di stare con gli altri e di essere accettato dagli altri, insomma del suo desiderio di vivere, diritto che per lungo tempo gli era stato negato.
Il gruppo ha agito da contenitore delle sue ansie, delle sue paure, rimandandogli un messaggio di accettazione delle sue difficoltà e di stimolo nelle sue possibilità di riscatto.
Inserito in tale contesto Francesco ha potuto anche vivere finalmente con più libertà momenti di un’infanzia e di una fanciullezza negate.
Quella di Alessandra* è anch’essa una storia di sofferenza con genitori che vivono in condizioni economiche molto precarie.
L’aspetto di questa storia che più mi ha colpito è stato il desiderio di questa ragazza di essere abbracciata dal padre ed il rifiuto di questi come risposta al bisogno di affetto della figlia.
Di qui le fughe ed il coinvolgimento in storie sbagliate anche con uomini molto più grandi di lei forse alla ricerca di quel contatto umano che sempre le è mancato.
Da principio il suo comportamento era provocatorio, poco responsabile, caratterizzato dal rifiuto delle proprie debolezze: non sentiva, o meglio non voleva avere bisogno dell’altro.
Un continuo e costante sostegno del gruppo ha permesso ad Alessandra di esprimere liberamente le proprie emozioni, in particolare il bisogno di essere protetta e di sentirsi amata.
11) Facciamo un passo indietro, il 2003 è stato l’Anno Europeo delle persone con disabilità, cosa ne è rimasto di positivo?
L’Unione Europea, decidendo di celebrare l’anno 2003, come l’Anno Europeo delle Persone con Disabilità, ha proposto alla riflessione e all’impegno delle nazioni e delle città europee un mònito che deve guidare tutte le decisioni da prendere circa i disabili: “Niente sui disabili, senza i disabili”.
L’Unione Europea ha inteso ribadire con forza che i disabili hanno gli stessi diritti fondamentali degli altri cittadini e che una società che esclude parte dei suoi membri è una società impoverita nella sua umanità.
La Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea riconosce infatti che, affinché i disabili possano raggiungere uno status di uguaglianza, il diritto a non essere esclusi deve essere associato al diritto ad usufruire di interventi che garantiscono la loro indipendenza, integrazione e partecipazione alla vita della comunità.
Il principio di uguaglianza di tutti i cittadini è sancito dall’art. 3 della nostra Costituzione, laddove affida allo Stato il compito di intervenire per rimuovere gli ostacoli di ordine sociale, economico, culturale e strutturale che impediscono l’inserimento e la partecipazione di tutti i cittadini alla vita del Paese, in modo che ogni persona, anche la persona disabile, possa davvero sentirsi “Cittadino”, ed in quanto tale godere di pari opportunità ed accedere indistintamente a determinate utilità sociali: quali l’istruzione (art. 34), la salute (art. 32) e il lavoro (art. 38).
E’ stato, il 2003, un anno che ha posto tutti noi nello spirito di interrogare la nostra coscienza su quello che avremmo dovuto fare, su quello che possiamo fare e su quello che dovremo fare; la risposta sta proprio nello slogan “niente sui disabili, senza i disabili” che deve guidarci sempre nel nostro operare quotidiano.
12) Come si può concretizzare questo slogan?
Queste storie personali di sofferenza, storie drammatiche e terribili, come altre che fanno parte della nostra vita di Comunità, sono testimonianze viventi di un crescere insieme, anche se non privo di difficoltà e di ansia per noi operatori.
Sono molti gli interrogativi che ci poniamo e ai quali molte volte facciamo fatica a trovare delle risposte.
Qual è il modo migliore per relazionarsi ad Attilio* completamente immerso in un mondo apparentemente privo di regole che protegge e difende con forza?
O con un ragazzo come Carlo*, chiuso nel suo impenetrabile isolamento, poco recettivo agli stimoli che gli provengono dall’esterno, con il suo corpo rigido?
O ancora come bilanciare l’influenza dei familiari con il vivere nella Comunità Alloggio od al Centro Diurno “L’ Aquilone”?
E come coinvolgere i familiari, stanchi e delusi, soli, abbandonati dalla società nella loro disperazione, in questo percorso di riscatto dei loro figli?
Come aiutare Gianni* a raggiungere un maggior livello di autonomia anche nelle azioni più semplici, (come sbucciare una mela), se viene soffocato da una madre che continuamente sostituisce al gesto spontaneo del figlio se stessa?
Il messaggio che spesso questi genitori danno ai figli è: tu non sei capace, tu non sei all’altezza.
Essi insegnano ai loro figli a non avere stima in se stessi, a non credere nelle loro possibilità.
In tal modo rafforzano il loro senso di inferiorità e mantengono quello stato di “essere malati” senza alcuna speranza di cambiamenti.
Ma di cambiamenti si vive e si deve vivere!
13) Quali sono stati i maggiori cambiamenti che ha vissuto la Comunità?
Questi ultimi tre anni sono stati per il gruppo dell’Aquilone tempi di crescita, non solo numerica, ma anche, e soprattutto, nell’evoluzione della consapevolezza della necessità di modificare l’organizzazione del lavoro.
L’”Aquilone” da “Associazione di Volontariato” si è trasformata in “Associazione di Promozione Sociale”, iscritta al relativo Albo Regionale per poter permettere uno sviluppo occupazionale degli operatori.
Anche alcuni ragazzi hanno cominciato a fremere, a differenziarsi e a fare richieste più specifiche rispetto alla loro esigenza di lavorare.
Questo ha provocato un po’ di insofferenza perché la strettoia in cui ci si sentiva non dava molta possibilità di vie di uscita.
Sappiamo tutti che l’”ex disabile mentale”, quantunque abbia urgenza di vivere nella comunità civile come soggetto attivo, abitualmente si trova discriminato quando cerca di inserirsi nel campo dell’occupazione.
E’ così stata progettata e realizzata una Cooperativa Sociale integrata per dare ai ragazzi la possibilità di veder realizzato un loro diritto essenziale, il diritto al lavoro.
La Cooperativa è stata intitolata a “Peppino Nocella”, studente universitario formiano disabile, ospite, nel periodo degli studi universitari, degli amici della Comunità di Capodarco di Roma e deceduto prematuramente a causa della propria disabilità.
14) L’ultima domanda, quali altri impegni ha oggi l’associazione?
Oggi l’impegno dell’Associazione l’”Aquilone” è indirizzato non solo alle persone disabili, ma anche verso tutti quelli che vivono la disperazione di una particolare esclusione sociale: i detenuti, con una esperienza molto forte nel carcere di Rebibbia, e le ragazze e i ragazzi di strada del Guatemala.
Tutto ciò come servizio particolare affinché ciascuno possa realmente arrivare ad essere artefice e protagonista della sua stessa vita, cercando così di modificare anche la realtà che ci circonda.
Un altro progetto concreto cui l’Associazione ha cominciato da tempo a lavorare è quello del “Dopo di Noi”.
Dopo una fase di progettazione è stata costituita con il contributo fondamentale dell’”Aquilone”, la “Fondazione Prima del Dopo Capodarco–ONLUS”; la Fondazione, costituita da tredici Associazioni del Lazio, è uno strumento con cui le famiglie e le loro Associazioni, insieme alla Comunità di Capodarco di Roma, promuove, a livello regionale, iniziative intese a garantire al disabile la maggiore autonomia possibile e la migliore capacità d’integrazione sociale nella prospettiva del “Dopo di Noi”.
Questo ambizioso progetto del “Dopo di Noi”, cioè dopo che i familiari non ci saranno più, sarà il forte impegno della Comunità L’”Aquilone” per i prossimi anni.
———————————–
* tutti i nomi sono fittizi.
**Salvatore Gentile nasce a Formia mercoledì 22 settembre 1943 nella zona storica di Castellone, in piena occupazione nazifascista, da Francesco e da Rosa Scipione.
Entra in seminario nel 1954.
E’ ordinato sacerdote il 18 luglio 1971 e consegue la licenza in Sacra Teologia presso la Pontificia Università Lateranense in Roma il 26 giugno 1972.
Negli anni settanta è animatore della Comunità Cristiana di Base di Formia frequentata da oltre 150 giovani provenienti anche dalle cittadine limitrofi.
Si laurea in Psicologia (Indirizzo Applicativo) presso l’Università “La Sapienza” di Roma il 7 marzo 1980, specializzandosi poi in Psicoterapia.
Dal 1972 al 1985 insegna Religione nella scuola media statale “P. Mattei” di Formia.
Nel 1982 fonda il Ce.P.I.S. “Centro di Psicologia ‘Individuo e Società’”, la cui denominazione indica in modo chiaro le finalità non ristrette ad un’azione rivolta solo agli individui, come tante psicoterapie utili al mantenimento delle cause sociali delle sofferenze individuali, ma aperto a tutto il contesto sociale.
Il 30 maggio 1990 ottiene la dispensa dal ministero sacerdotale, e decide di vivere da laico per meglio rispondere al profondo ideale di fare sue le sofferenze altrui, per lenirle e plasmarle in un comune fraterno e amichevole cammino.
Nel 1993 prende corpo la comunità “L’Aquilone” di cui ne è l’ispiratore, fondatore e tuttora animatore.
Tutt’oggi, circondato dall’affetto e dall’impegno di ex tirocinanti, oggi psicologi e psicoterapeuti, svolge la professione di psicologo-psicoterapeuta.
Dice di Salvatore Gentile, il Poeta e Critico letterario, Rosario Garofalo:
Salvatore è nato e vive a Formia, un angolo del mondo dove la felicità ha il sapore delle piccole cose ed il profumo carismatico di antico si confonde con il progresso che, prepotente, cerca di cancellare i segni della storia.
Ma Salvatore la storia la porta con se: è nel suo DNA, racchiusa nello scrigno dei ricordi, dove vivono imponenti gli anni della sua infanzia, nonché quelli della vita sacerdotale che non ha mai abbandonato spiritualmente, ma che ha voluto continuare, sia pure per strade diverse ma altrettanto tortuose, senza mai perdere di vista l’inconfondibile meta: il desiderio ideale e profondo di fare sue le sofferenze altrui per plasmarle, lenirle e regalare i colori vivi della vita, offuscati dall’impatto inevitabile con il vissuto.
Si laurea in psicologia all’Università di Roma e, Icaro di una “nuova forma” che tanto lo distacca dalla scuola di chi, assetato di potere, ha fatto della psicologia un arido mestiere, inizia il suo volo pindarico negli spazi annebbiati degli animi umani.
Ma Salvatore non ha ali di cera e il suo volo continuerà, alimentato da un unico ed inesauribile propellente: l’amore verso un mondo che ha smarrito le esatte coordinate fra l’Essere e l’Apparire.
E’ da questo amore verso l’”altro sofferente”, che ne fa condividere le sofferenze, che ne fa curare le ferite e le fa fasciare versandovi olio e vino, prendendosene cura in prima persona (Lc. Buon Samaritano, 10, 30-37), che è nata, con spirito cristiano, l’esperienza comunitaria dell’”Aquilone”.